Circolazione opere d'arte a fiscalità variabile
L'articolo analizza le recenti disposizioni legislative relative alle agevolazioni fiscali nel settore dell'arte, con particolare riferimento alla tassazione dei guadagni derivanti dalla compravendita di opere d'arte e oggetti da collezione. Viene discusso l'intento speculativo come criterio per determinare la tassazione e l'auspicio di un regime fiscale semplificato per mercati peculiari e volatili.
ARTICOLI
Edoardo Belli Contarini - Il Sole 24 Ore
9/13/20232 min read
Il settore dell'arte continua a essere attenzionato dal legislatore; oltre al Ddl di riforma fiscale, si aggiunge un altro Ddl sulle agevolazioni fiscali e sulla semplificazione della circolazione per le opere d'arte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° luglio 2023).
Quanto al primo aspetto, per dirimere la disputa sulla imponibilità dei guadagni dei dealer di quadri, oggetti preziosi e da collezione (Cassazione 6874/2023), l'articolo 5 del primo Ddl contempla la tassazione Irpef, e non già un'imposta sostitutiva proporzionale, a meno che risulti assente la finalità di lucro. Non c’è speculazione nei casi di reinvestimento del corrispettivo entro un congruo periodo di tempo in beni della stessa natura o di acquisizione ereditaria o a titolo gratuito, ferma restando l’azione erariale di simulazione delle donazioni.
Al di fuori di questi casi però, le plusvalenze scaturenti da attività commerciali occasionali sono sempre assoggettabili all'Irpef ex articolo 67, lettera i) Tuir. L'intervento normativo supera l'incertezza sugli «indicatori di commercialità» elaborati dalla prassi, tant'è che si prevede anche una disciplina transitoria (si veda la relazione).
In effetti, l'obiettivo della certezza del diritto emerge spesso nella delega fiscale, come rilevato da Assonime e dalla Banca d'Italia (si vedano rispettivamente la consultazione 9/2023 e la memoria della stessa Banca). Tuttavia, qualche dubbio rimane, anzitutto sulla rilevanza dell'imperscrutabile intento speculativo.
In un mercato asfittico, i risparmiatori, gli investitori e gli appassionati si sono rifugiati negli asset digitali – criptovalute, token, NFT – e nelle opere d'arte, incassando guadagni cospicui. Il legislatore è intervenuto quasi subito, riconducendo i proventi da cripto-attività in una nuova categoria dei redditi diversi (articolo 67, lettera c-sexies Tuir); analoga sorte avrà il commercio occasionale degli oggetti da collezione, salvo che risulti assente l'intento speculativo.
Il concetto di intent speculativo, affatto nuovo, è tuttavia troppo vago, dato che lo scopo lucrativo non può rilevare in sé, ma è decifrabile dai comportamenti, dagli atti e dalle operazioni poste in essere. È il fine che giustifica i mezzi, non il contrario. Il riferimento all'animus lucrandi non appare efficiente, trattandosi di un requisito soggettivo già sperimentato, con scarso successo, nella riforma degli anni '70.
Gli articoli 76 e 80 del Dpr 597/1973, con il Dpr 917/1986, furono abrogati per improntare l'Irpef al principio di tassatività. L'imposta è stata strutturata "a numero chiuso", eliminando la rilevanza sia della finalità speculativa sia del holding period biennale delle opere d'arte, superato il quale non assumeva più rilievo la rivendita.
Inoltre, il settore dell'arte viene inciso da un prelievo progressivo, incluse le ingenti addizionali locali, e non già da una tassa piatta. In forza del principio di progressività, salvaguardato dalla stessa riforma, sarebbe sconsigliabile un'ulteriore flat tax, tanto più che l'Irpef risulta inflazionata (per esempio la cedolare secca per le locazioni degli immobili abitativi, che verrà estesa ai cespiti a uso commerciale, la flat tax per gli autonomi, la flat tax incrementale, ecc.).
Tuttavia, in alcuni segmenti di mercato, caratterizzati dalla peculiarità degli asset scambiati, dalla volatilità dei prezzi e dalla difficoltà di documentare i costi o i valori di provenienza, sarebbe auspicabile un regime semplificato di tassazione sostitutiva e/o di forfettizzazione degli oneri di acquisizione e conservazione delle opere di valore, sulla falsariga delle cessioni dei metalli preziosi (articoli 67 e 68 Tuir).
L'intervento legislativo, ritornando al passato, non sembra migliorare la situazione, in un contesto che già contempla norme di chiusura (articolo 67, lettere h), i) e l) Tuir).
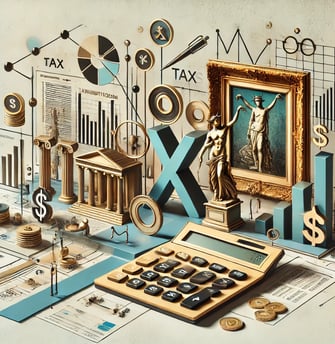
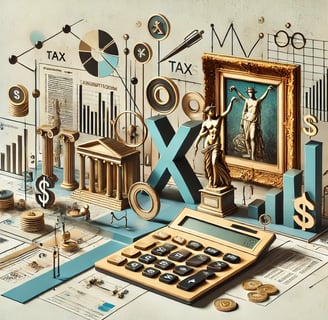

Termini di Servizio
Informazioni Legali
Social Media
Contatti
+39 3475428664
ebcontarini@fantozzieassociati.it
